Costarainera. Nuovo appuntamento con la storia locale a cura dello storico Andrea Gandolfo. Questa settimana è dedicato al paese di Costarainera, che raggiunse l’autonomia comunale nel 1815, fu poi aggregato al Comune di Cipressa nel 1928 e riassunse l’autonomia comunale nel 1954:
“Il paese, situato all’altitudine di 234 metri sul livello del mare, si estende su una collina posta alle pendici meridionali del colle della Costa, da cui si domina la vista sul mare e sulla valletta sottostante, circondata da vaste fasce coltivate a fiori e da terreni disseminati di uliveti. Il borgo, costituito in prevalenza da un agglomerato di case di pietra sfiorato dalla strada carrozzabile che sale da San Lorenzo al Mare e prosegue per la vicinissima Cipressa, presenta caratteristiche simili a quelle dei centri vicini ubicati sulle colline costiere con una struttura fortificata in funzione antibarbaresca e case di epoca tardomedievale prospicienti stretti vicoli e piazzette, spesso coperte da terrazze in linea con l’usanza tipicamente mediterranea dello spazio sommitale.
Il nucleo abitato di Costarainera si formò probabilmente nel corso del XIV secolo per motivi di natura demografica ed economica dovuti all’aumento della popolazione e alla conseguente necessità di coltivare terreni più estesi da parte di gruppi di famiglie provenienti da Cipressa e da Lingueglietta, i quali costruirono qualche abitazione ai confini del territorio comunale, dove esisteva anche un’abbondante sorgente d’acqua in grado di rifornire quella zona dell’indispensabile elemento per la vita di persone e animali. Il borgo, sovrastato già da alcuni secoli dalla chiesa di Sant’Antonio, si sviluppò quindi ulteriormente durante il XV secolo, quando nuove famiglie si trasferirono nella località resa accogliente dal duro lavoro agricolo e sulla quale nuove case si addossarono a quelle costruite in precedenza tanto che, dalla metà del Quattrocento all’incirca in poi, il primitivo nucleo abitato divenne un paese vero e proprio.
Sulle origini del toponimo, indicato nella dizione locale come a kòsta “la costa”, per antonomasia, si ipotizza un collegamento con la posizione geografica del paese su uno sperone che si affaccia sul mare, anche se l’etnico kosténgu, derivato con il suffisso di origine germanica -ingo, attesta in modo inequivocabile l’origine medievale dell’insediamento. Al toponimo iniziale fu più tardi aggiunto l’epiteto de Ranieri, attestato per la prima volta in modo ufficiale nella cartografia settecentesca, forse derivato dal cognome di uno o più casati residenti in passato nel paese e poi concresciuto nel toponimo attuale tramite la sua concordanza al femminile con il prefisso Costa.
Le origini del paese risalgono alla donazione fatta dalla contessa Adelaide di Susa pochi decenni dopo l’anno Mille al monastero di Santo Stefano di Genova di un ampio tratto costiero nella zona chiamata Villaregia a sud di Cipressa, il quale, già esistente con annessa parrocchia nel 1153, si trovò con Terzorio e il poco territorio circostante a confinare con potenti vicini, finendo con l’essere inglobato nel feudo di Villaregia nel 1225.
La saggia amministrazione dei monaci benedettini comportò per la popolazione di tutti i paesi che costituivano il Principato di Villaregia una ragguardevole prosperità economica ed una notevole forza di espansione che spiega la nascita di nuovi centri abitati tra i quali anche quello di Costarainera. L’ingrandimento territoriale dei vari borghi e il relativo aumento della popolazione si tradusse pure nella inevitabile necessità da parte degli abitanti di nuovi spazi per le coltivazioni, i pascoli e l’utilizzo della legna da ardere, tanto che non furono rare, nel corso del XIII secolo, le liti e le controversie tra l’abate di Santo Stefano e i signori di Linguilia, soprattutto per motivi legati alla delimitazione dei rispettivi confini.
Tali vertenze non cessarono nemmeno dopo la cessione dei possedimenti benedettini, avvenuta tra il 1335 e il 1353, alla Repubblica di Genova, come documentato dalla sentenza emessa nel 1358 da Maurizio Cattaneo per mettere d’accordo gli abitanti di Lingueglietta con quelli di Terzorio e Cipressa, mentre nel 1386 e nel 1387 altri documenti tramandano l’avvenuta insorgenza di varie liti per questioni confinarie tra Lingueglietta e Santo Stefano, anche se, per l’incompletezza di tali atti, non è possibile accertare se in essi è nominata la località di Costa, che allora aveva il nome di Sabina, prendendo poco tempo dopo il nome «dei Raineri», derivato probabilmente – come già accennato – dal cognome delle famiglie che per prime vi avevano costruito le loro abitazioni. In un successivo arbitrato, pronunciato da Luca Grimaldi nel 1454 per dirimere le controversie di confine sorte tra le comunità di Santo Stefano e di Lingueglietta, è stata invece delineata con precisione l’area pretesa dalle due comunità, che era compresa tra la foce del torrente di Civezza, oggi detto San Lorenzo, e le vicinanze di Castellaro, seguendo il crinale delle colline e quindi passando anche per zona dell’odierna Costarainera, che peraltro non viene citata nel documento.
I patti di divisione stabiliti con questa sentenza erano peraltro destinati a durare per pochi anni in quanto si rese presto necessario un nuovo accordo tra le parti, che venne stipulato il 5 gennaio 1467 tra i rappresentanti di Lingueglietta e quello di Cipressa, Santo Stefano e Terzorio, i quali si accordarono sulla delimitazione dei confini esterni con il feudo di Castellaro-Lingueglietta con un atto particolarmente significativo perché nella descrizione del primo tratto di confine, dalle case presso San Lorenzo al mare, è nominato il colle Falodio e la Costa, Villa dei Raineri, e subito dopo il poggio Sabino, ossia lo Rosoreo.
È questa la prima citazione certa del paese di Costarainera, che doveva essere quindi già formato, anche senza una propria autorità e figura giuridica in quanto il borgo viene menzionato sotto la giurisdizione di Cipressa. Otto anni dopo fu invece la volta della compilazione dei locali Statuti, che furono redatti nel 1475 in sostituzione di quelli emanati dai monaci benedettini nel 1217 e nel 1277, tenendo conto non solo della legislazione corrente, e specialmente delle disposizioni già codificate nel 1381 nello Statuto di Taggia, ma anche delle consuetudini non scritte delle comunità di Terzorio, Cipressa e Pian della Foce, con l’intenzione di fissare delle norme che tutti gli abitanti avrebbero dovuto rispettare a garanzia di parità nella giustizia e conseguente abolizione dei privilegi in modo che tali leggi fossero l’espressione diretta della volontà popolare.
Nel corso del XVI e XVII secolo, pur rimanendo ancora formalmente in vigore gli Statuti del 1475, il territorio di Cipressa, dal quale dipendeva Costarainera, era retto da due consoli nativi del paese, che venivano nominati ogni anno dal Parlamento locale e ai quali era affidata l’amministrazione del paese e in particolare della giustizia. Tale sistema comportò peraltro l’insorgere di prepotenze e abusi da parte di alcune famiglie del luogo particolarmente ambiziose e potenti, tanto che alla fine dovette intervenire direttamente il governo della Repubblica, che inviò in Riviera i commissari sindicatori Andrea Imperiale e Camillo Moneglia per effettuare dei sopralluoghi, al termine dei quali i due rappresentanti del governo genovese emanarono, il 25 maggio 1607, un loro decreto che semplificava la nomina dei nuovi consoli stabilendo che i consoli uscenti, senza votazione, avrebbero dovuto eleggere i loro successori.
Rispettate queste nuove regole per qualche decennio, nel 1644, montate nuove proteste per il fatto che il potere rimaneva sempre in mano di un ristretto numero di medesime famiglie, il Magistrato della Comunità di Genova ordinò il ritorno all’antico sistema di nomina mediante votazione in Parlamento, motivando la sua decisione, stranamente presa senza averne informato il Senato, con il grave danno arrecato alla comunità dal fatto che la gestione della cosa pubblica rimaneva sempre affidata ad un ristretto gruppo di quattro o cinque persone, per cui si rendeva necessaria una riforma degli Statuti, che venne approvata dal Senato il 1° settembre 1651.
Per evitare o almeno limitare le eventuali ingiustizie derivanti dalla ripartizione delle quote delle tasse, dette allora avarie, tra i cittadini, il governo della Repubblica diede ordine perentorio alle autorità locali nel 1641 di redigere un catasto-censimento di tutti i beni pubblici, privati ed ecclesiastici delle varie comunità, che sarebbe stato controllato da appositi funzionari del governo inviati in tutte le località del territorio genovese. Prima ancora dell’arrivo dei delegati dalla capitale, ogni comunità doveva riunire il locale Parlamento per i necessari lavori preparatori.
A Cipressa tale adunanza ebbe luogo il 15 settembre 1641 nella piazza davanti alla Curia finito il Vespro, quando la maggioranza dei rappresentanti della popolazione elesse quattro estimatori con il mandato di valutare i beni del territorio cipressino, diviso da quello di Terzorio, Pian della Foce e Santo Stefano, senza peraltro nessun accenno a Costarainera, che era evidentemente ancora considerata parte integrante di Cipressa, nella quale era inglobata senza alcuna distinzione nel catasto in oggetto, che venne quindi approvato dai due rappresentanti del governo genovese Gian Battista Brea e Luca Clavarino, dopo aver attentamente e scrupolosamente visitato tutte le proprietà pubbliche e private, tra le quali in particolare le tenute agricole, del territorio di Cipressa e Costarainera. È molto probabile che la compilazione di tale catasto abbia aumentato i dissapori tra il centro di Cipressa e la borgata di Costarainera, rendendo sempre più stringente e viva l’ipotesi di separare i due centri, che decisero quindi di dividersi sotto l’aspetto religioso con la rinuncia della popolazione di Cipressa al diritto sulla chiesa di Sant’Antonio e la costruzione di una nuova chiesa dedicata alla Visitazione di Maria Vergine, dalla quale venne ufficialmente separata la parrocchia di Sant’Antonio con decreto del 18 novembre 1654.
Tale separazione non impedì tuttavia il verificarsi di numerosi dissidi e controversie tra le due comunità, tanto che il rettore della chiesa di Costarainera si dovette lamentare più volte con il Senato genovese della mancata corresponsione dell’offerta da parte degli abitanti di Cipressa, che dal 1753, per protesta, arrivarono persino a disertare le cerimonie religiose e civili. Ai motivi di contrasto religioso si aggiunsero ben presto anche quelli di natura economica, derivanti soprattutto dal fatto che Cipressa godeva di maggiore potenza in campo laico, civile, sociale ed economico anche perché Genova conosceva il comune di Cipressa ma non quello di Costarainera, che, pur facendone parte integrante, non esisteva in forma autonoma.
Tale situazione era ulteriormente aggravata dal ripetersi di frequenti atti di ostilità tra Cipressa e il confinante paese di Lingueglietta, che vantava diritti giurisdizionali non solo sul territorio ma anche su un parte delle case di Costarainera, dove era sorto tra il XIV e il XV secolo un gruppo di abitazioni senza avere la compattezza di un vero paese con popolazione organizzata e retta da propri consoli, tanto da essere conteso tra Cipressa, con cui era unito per popolazione, e Lingueglietta, che invece rivendicava dei diritti sul territorio. Nonostante ciò, gli abitanti di Costarainera si sentivano uniti a quelli di Cipressa, con i quali formavano un’unica amministrazione comunale, avevano un unico Parlamento (anche se spesso disertato dai Costenghi) ed erano governati da un solo gruppo di autorità locali, insieme alle quali si opponevano da secoli alle mire espansionistiche del limitrofo feudo dei Linguilia, che ambivano all’estensione dei loro confini fino alla costa, dove appunto sorgeva il paese che ne ha preso il nome.
Le liti per i confini, intanto, non cessavano tanto che nel 1734 i censori di Cipressa fecero arrestare un certo Giacomo Spinelli, gestore di un’osteria a Costaraniera, suscitando la ferma protesta dell’autorità comunale di Lingueglietta, che rivendicava come parte integrante del suo territorio tutta la località di Costarainera. Investito della questione il governo della Serenissima, questo incaricò il commissario generale di Sanremo Camillo Doria di indagare sul fatto, sul quale il funzionario genovese stilò una relazione il 28 febbraio 1735 invocando l’intervento dell’ingegnere Matteo Vinzoni per fissare i confini, delineare le case e misurare il territorio controverso, cioè quello di Costarainera, che venne accuratamente e minuziosamente descritto dal grande cartografo genovese.
La decisione dei due periti nominati dalle parti, Gio Stefano Asdente e Antonio Maria Bottini, in qualità di Consultori della Giunta dei Confini, si tradusse nella singolare sentenza di dividere l’abitato di Costarainera da Nord a Sud seguendo la strada principale del paese: le case a ponente sarebbero spettate a Cipressa mentre quelle a levante avrebbero dovuto essere assegnate a Lingueglietta. Le pratiche per la delimitazione dei confini si protrassero quindi fino al 1738, quando, il 29 e 30 dicembre di quell’anno, il commissario generale di Sanremo, accompagnato dai quattro consoli di Lingueglietta e a spese del Comune di Cipressa, si recò a Costarainera per fissare con termini in pietra i tanto discussi confini, che sarebbero stati però divelti nella notte del 10 gennaio dell’anno successivo, forse dagli abitanti di Lingueglietta, contro i quali i Cipressini minacciarono allora di scatenare un’autentica guerra civile, poi scongiurata dall’intervento del governo genovese che ribadì la validità del decreto concernente i confini tra le due comunità.
La delimitazione dei confini non portò comunque alla fine delle controversie, legate soprattutto alla questione del pagamento delle tasse al governo genovese da parte degli abitanti di Cipressa e Costarainera, i quali si rivolsero allora al Senato della Repubblica, che il 24 settembre 1753 emanò un decreto contenente alcune norme relative al modo di valutare e stabilire le quote spettanti a ciascun paese senza tuttavia dirimere l’annosa questione, per la cui soluzione i rappresentanti di Cipressa e Costarainera si recarono più volte a Genova nell’estate del 1755, ma le parti avverse non avrebbero trovato un accordo soddisfacente tanto che una supplica spedita da Costarainera al Senato, e da questo discussa il 18 aprile 1757, dimostra chiaramente che, a quella data, si era ancora ben lungi dall’accomodamento del litigio.
Nel gennaio 1709 si era intanto verificato un gelo particolarmente intenso e duraturo che provocò anche a Costarainera gravissimi danni alle coltivazioni, soprattutto di ulivo, ai vigneti e agli alberi da frutta, che andarono in gran parte distrutti, mentre una carestia, scoppiata nei mesi successivi aggravò ulteriormente la già critica situazione economica degli abitanti del paese per via della mancanza di grano e degli altri cereali quali orzo e segala, i cui prezzi salirono alle stelle. Durante la successiva guerra di successione austriaca anche la zona di Costarainera subì vari saccheggi da parte delle truppe in transito, e in particolare quelle austriache dirette verso occidente e poi quelle franco-spagnole, che marciavano in aiuto dell’alleata Repubblica di Genova.
Tale passaggio, che fu certamente dannoso per i campi del comprensorio, ebbe peraltro conseguenze positive per le popolazioni della zona sempre affamate in quanto i soldati permisero la conoscenza e la diffusione della coltivazione della patata, dei pomodori e di altri prodotti utili, provenienti in gran parte dall’America e destinati a diventare parte integrante del vitto dei contadini del Ponente soprattutto durante i periodi di carestia in sostituzione del pane, che era allora una delle principali fonti di sostentamento. Nel corso del successivo periodo di occupazione francese, iniziato nell’aprile 1794, i rivoluzionari giacobini effettuarono razzie nei magazzini di viveri, asportarono prodotti dalle campagne e saccheggiarono le abitazioni private, mentre, dopo la proclamazione della Repubblica Ligure nel 1797, anche nella zona di Costarainera furono aboliti i titoli nobiliari e scalpellati gli stemmi delle famiglie nobili, con qualche disagio per i nobili Linguilia a Lingueglietta, dove la reazione popolare non fu comunque particolarmente violenta.
L’ordine del governo giacobino di requisire gli oggetti preziosi contenuti nelle chiese provocò invece dei malumori tra gli abitanti di Costarainera, che, per salvarne almeno una parte, si autotassarono versando alle autorità centrali il corrispondente valore in denaro degli oggetti sacri o una percentuale del 4% per conservarne l’uso, mentre il 4 settembre 1797 il governo democratico genovese incaricava i due cittadini estimatori Gio Batta Gandolfo e Gio Batta Spinello di valutare i beni della parrocchia, che furono stimati 8931 lire con un reddito che, tassato al 4% secondo quanto stabilito dalla legge, imponeva una tassa pari a 357,4 lire, alla quale si sarebbe dovuta aggiungere la tassa del reddito dei censi e livelli, valutata 95,4 lire. Annessa la Liguria all’Impero francese nel 1805, anche la zona di Costarainera subì le pesanti conseguenze del nuovo regime, e in particolare l’aumento del prezzo dei viveri, l’inserimento della burocrazia in ogni attività con l’obbligo di usare la lingua francese, e soprattutto l’introduzione della leva militare obbligatoria, che sottrasse numerose braccia giovanili al lavoro agricolo, reso ancora più duro dalla scarsità dei rifornimenti di grano e dal misero guadagno derivante dalla vendita di vino e olio.
Con la caduta di Napoleone, anche la popolazione costenga salutò con gioia la fine del regime francese e il passaggio di papa Pio VII dalla Riviera nel 1814, preludio all’annessione della Liguria al Regno di Sardegna nel 1815, quando Costarainera conquistò finalmente l’autonomia amministrativa diventando Comune, retto da un sindaco nominato dal governo sabaudo, che eleggeva pure i suoi collaboratori, che sarebbero poi stati votati da una parte della popolazione.
Nei decenni successivi la zona di Costarainera fu colpita da vari eventi calamitosi, come il maremoto del 1821, che causò l’affondamento di molte barche e la cupola della chiesa parrocchiale, il terremoto del 26 maggio 1831 e quello più disastroso del 23 febbraio 1887, che provocò qualche danno ad alcuni edifici senza causare peraltro morti o feriti gravi, per cui l’anno dopo il governo concesse al Comune di Costarainera 475 lire per la riparazione del Municipio, 2700 lire per le opere pie, 3865 lire per la chiesa e gli oratori, mentre a tre privati venne concesso un mutuo, pari a 4000 lire, per la riparazione delle loro case. Dopo la prima guerra mondiale, nella quale caddero numerosi militari costenghi, il paese venne unito, nell’ambito della generale riorganizzazione amministrativa attuata dal regime fascista, al Comune di Cipressa in esecuzione del regio decreto n. 161 del 26 gennaio 1928. Dopo la stipulazione dell’armistizio con gli Alleati, Costarainera fu invasa il 30 e 31 maggio 1944 dai fascisti, che si abbandonarono a saccheggi e rapine, mentre molte abitazioni furono perquisite e la popolazione fu sottoposta a umilianti maltrattamenti.
Il 1° gennaio ’45 anche i Tedeschi perquisirono le case del paese fermando una ventina di persone, poi rilasciate tranne tre, tra le quali il garibaldino Ettore Ardigò, che, arrestato dai nazifascisti a Costarainera il 13 dicembre ’44, venne poi fucilato a Capo Berta il 30 gennaio dell’anno successivo, mentre fornì un prezioso contributo all’attività delle forze partigiane il locale CLN, formato dal comunista Francesco Garibaldi, dal democristiano Paolo Fossati e dall’indipendente Antonio Gandolfo. Dopo la fine della guerra si ripropose la questione della separazione di Costarainera da Cipressa, per cui il 21 maggio 1948 circa trecento Costenghi inviarono una petizione al ministro dell’Interno Scelba e al presidente della Repubblica Einaudi per chiedere la separazione del loro paese da Cipressa, motivando tale richiesta con il fatto che dalla loro unione con il Comune cipressino essi non avevano ricavato alcun beneficio concreto e, in particolare, si lamentavano di aver subito un gravissimo danno economico a causa dell’esproprio delle terre comunali della fascia costiera, dove erano stati costruiti gli istituti sanatoriali dell’INPS, i relativi parchi e i terreni per la coltivazione degli ortaggi.
Accolte quindi tali rimostranze dei Costenghi, le autorità centrali sanzionarono la separazione da Cipressa di Costarainera, che riacquistò l’autonomia comunale in forza del decreto del presidente della Repubblica n. 285 del 27 marzo 1954, poi pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 137 del 18 giugno successivo. Nel secondo dopoguerra ha ripreso inoltre nuovo impulso l’economia locale, basata soprattutto sulla floricoltura e l’olivicoltura, mentre pure il settore turistico ha registrato un discreto incremento grazie anche alla presenza di un ristorante-albergo ben attrezzato in grado di offrire agli ospiti del paese un piacevole soggiorno”.
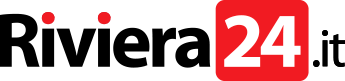




commenta